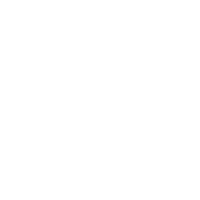Il più grande pervertimento della concezione popolare sulla nascita è iniziato quando i valori di efficienza e velocità postmodernisti si sono applicati all’assistenza medica al parto, il che ha coinciso con l’incistarsi, nei nostri sistemi sanitari, di pratiche culturali antiscientifiche divenute norma, poi abitudine e ora difficilissime da scardinare, a dispetto di tutta l’evidenza scientifica e del buon senso. La più comune lesione all’integrità del processo commessa al parto è la separazione del neonato dalla madre. Il parto visto come un’espulsione, giustifica pratiche culturali dannose e inutili, molte delle quali in uso ancora oggi, come il taglio del cordone a pochi secondi o minuti dalla nascita, la visita neonatologica lontano dalla madre, le terapie neonatali e la toeletta di rito nella prima ora o primi minuti dalla nascita.
Il parto non è un’espulsione; a ben vedere implica una serie di espulsioni dal corpo materno (liquido amniotico, bambino, annessi, sangue, altri liquidi) ma non è questo il suo fine. La biologia non sarebbe soddisfatta dalla mera espulsione di A da B. Lo scopo della nascita è che A incontri B. La nascita è un incontro, forse l’incontro per antonomasia, con caratteristiche comprensibili solo con un pensiero magico: è infatti sia un imprinting, una prima volta per madre e bambino, sia un riconoscimento reciproco; come nelle migliori storie d’amore, ma senza la patina di Hollywood.
Non esiste un neonato, esiste un neonato e qualcuno
Donald Winnicott
La nascita è una danza tra azioni e pause
Con tutte le sue complessità e individualità questo incontro non deve essere ideale né idealizzato, è importante però riconoscerlo come fenomeno biologico del parto.
La nascita, per il bambino come per la mamma, è fatta di azioni e pause, di contrazioni ed espansioni, di slanci coraggiosi seguiti da sospensioni di tempo e giudizi, di emozioni travolgenti e di inconsce integrazioni. È una danza tra polarità: le tempeste del corpo e dell’anima si placano in una frazione di secondo, e quando il movimento riprende si è in una fase successiva. Riusciamo, come umani, a pensare a uno stretching più polarizzato di quello che vivono mamme e i bambini nelle fasi della nascita? Eppure questa nascita non è un caos, ha i suoi ritmi e come tali una sua forma di prevedibilità biologica. Cioè, intendiamoci, non c’è nascita che sia uguale a un’altra poiché nascere e partorire sono azioni fatte da persone, e ogni persona, si sa, è diversa; eppure questo ritmo si mantiene intatto, generazione dopo generazione.
I quattro tempi del parto: il tempo dimenticato dell’incontro
Nei nostri libri si è voluto dividere questa danza in tre tempi, i tre stadi del parto descritti nella letteratura medica: dilatante, espulsivo, secondamento. Ogni doglia è seguita da una pausa fino alla dilatazione completa della bocca uterina. E questo è il primo tempo del parto. Il secondo tempo inizia con una transizione e poi lascia il passo al periodo espulsivo attivo, in cui la polarità tra azione e sospensione, emozione e integrazione, diviene estrema: le donne ammantate di rinnovato vigore spingono attivamente i loro bambini che a loro volta si impegnano con movimenti di propulsione e flesso-estensione per nascere. Nelle pause lo stato alterato di coscienza (ASC – Altered State of Conciousness) porta la neuromodulazione materna e fetale alla sua massima espressione, dove raggiunge il suo potenziale più protettivo: protegge il perineo e la psiche materni dai traumi e protegge il cervello fetale dalla paralisi. L’ultima spinta espulsiva porta alla nascita del bambino e lì, per la mamma, per il neonato o per entrambi, avviene una pausa. In questa pausa avviene la sospensione del tempo, la sospensione del fare.
La grande espansione dei corpi, quello materno per fare spazio al bambino e quello del bambino per estendersi e uscire dal canale del parto, ora vede una piccola contrazione, un momento di integrazione inconscia. Può essere visibile o meno, può esserci silenzio oppure madre o bambino o entrambi piangono, comunque entrambi respirano, prendono fiato, dopo il viaggio che hanno fatto ed è comune che si prendano ognuno un momento per sé. Come per il secondo stadio, anche il terzo inizia con una transizione, una pausa. Il terzo tempo del parto non sarà l’espulsione della placenta, bensì l’incontro. É un tempo organico e, come vedremo, propedeutico al quarto tempo: una nuova contrazione, una nuova espulsione: la nascita della placenta.
Separazione sanitaria routinaria e il paradosso della zero separation
Il paradosso della medicina moderna sta nell’avere individuato chiaramente i benefici della non separazione del neonato dalla madre, ma di averla perorata solo per quei bambini nati prematuri nei quali i danni da separazione sono più evidenti (disabilità, morbidità, morte). La EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants), supportata dalla SIN (Società Italiana di Neonatologia) e da tante altre società scientifiche, ha dato vita alla campagna e al movimento di sensibilizzazione zero separation, proprio per attenzionare i rischi della separazione alla nascita dei prematuri. E i bambini a termine?
Quando i danni da separazione sono invisibili al personale di sala parto (ostetriche, ginecologi, neonatologi, infermiere pediatriche) è perché sono danni che si renderanno visibili nei giorni, nelle settimane successive, fino alle modificazioni epigenetiche. Nel dopo parto le conseguenze ricadranno sulla qualità di vita fisica e mentale delle madri, dei neonati e delle intere famiglie. Nulla di cui chi lavora in sala parto dovrà occuparsi e di cui nemmeno sarà edotto, visto che il sistema sanitario non prevede la continuità dell’assistenza.
Chi invece lavora con la continuità assistenziale tra gravidanza, nascita e dopo parto, riconosce chiaramente i danni di una separazione dopo una nascita (medica, fisiologica o chirurgica che sia) a termine. Il pervertimento del comportamento neonatale, l’assenza o il ritardo dei riflessi neonatali al seno, il conseguente ritardo della montata lattea con sintomi amplificati, l’ipoglicemia neonatale, la disidratazione che rende rischiosa l’iperbilirubinemia, i pianti delle mamme disorientate, il ricorso disperato ad aggiunte di latte artificiale che mina il proprio senso di competenza materna. Siamo tra i Paesi europei con il più basso tasso di allattamento al seno a tre mesi dal parto (indicatore di per sé di qualità di cure ostetriche) a fronte di oltre il 90% di donne in gravidanza che dichiarano di desiderare allattare i loro bambini (dati del centro epidemiologico italiano).
“Attualmente, le cure materne e neonatali occidentali si basano in larga misura sulla separazione di routine tra madre e neonato. Si sostiene che non esiste un razionale scientifico per questa pratica e che ora esiste un corpo di nuove conoscenze che sostengono la necessità di una separazione zero tra madre e neonato. Per il neonato, la promozione della separazione zero si basa sulla necessità di input sensoriali materni che regolano la fisiologia del neonato.
Nella madre sono necessari processi neurali che assicurano una maggiore idoneità riproduttiva, compresi cambiamenti comportamentali (ad esempio, legame e protezione) e una migliore lattazione, che sono supportati dalla pratica della separazione zero. La separazione zero tra madre e neonato dovrebbe quindi essere mantenuta a tutti i costi nei servizi sanitari.” (Bergman, 2014)
Come implementare la non separazione alla nascita?
Implementare il rispetto del terzo tempo del parto è stato fatto in diverse realtà ma ancora troppo poche. Non solo nel parto vaginale ma anche in contesto di taglio cesareo, il bambino appena estratto può essere passato alla mamma, mantenendo intatto il suo cordone. Questo livello di progresso nell’assistenza al parto avviene tramite la formazione degli operatori, ma anche la condivisione di paure e dubbi, l’accoglienza delle incertezze. Non bastano le raccomandazioni, serve la spinta profonda al cambiamento.
Alcune famiglie, in Europa, hanno spinto il cambiamento “dal basso” (espressione riferibile a un sistema che pone le famiglie all’ultimo gradino della gerarchia di potere, all’interno degli ospedali). Per farlo hanno utilizzato l’escamotage del diritto al rispetto religioso. I genitori hanno infatti dichiarato di avere un proprio culto che prevede di tenere il bambino con la madre alla nascita per un rituale di preghiera della durata variabile. Questo ha impedito agli operatori di separare i bambini per i rituali sanitari.
L’obiettivo dovrebbe essere il riconoscimento condiviso della non separazione come un diritto di mamme e bambini, includendo nello scenario i bisogni degli operatori per poter sostenere il cambiamento.
Le donne hanno il diritto al loro tempo individuale per l’incontro, che include il diritto di non prendere o non ricevere immediatamente il bambino addosso dopo l’espulsione. I bambini hanno diritto alla transizione assistita dalla loro placenta e a una nascita rispettosa della loro umanità, che è anche la nostra.
Cambiare paradigma, forma e strutture: la rivoluzione dell’assistenza al parto inizia con la frase “io non separo”
“L'assistenza alla coppia madre-neonato richiede un cambiamento dei sistemi sia in ostetricia che in pediatria, considerando la pianificazione e l'organizzazione dell'assistenza, le attrezzature e la progettazione delle unità. Di conseguenza, una leadership forte che fissi obiettivi chiari e cambi la mentalità professionale fornendo un'istruzione e una formazione mirate è fondamentale per garantire l'alta qualità garantita dell'assistenza a tutte le diadi madre-neonato.” (Klemmings e colleghi, 2021)
Piani, protocolli, organizzazioni, sono astrazioni umane. Credo fortemente che il cambiamento di assistenza passi attraverso il risveglio della coscienza umana personale e professionale degli operatori che, al momento della nascita, hanno il POTERE di separare o non separare un bambino dalla madre. Credo fortemente nel senso di responsabilità di ciascuno e nella fermezza di opporsi alla separazione. Quando sei lì con le forbici in mano per tagliare un cordone puoi decidere di non farlo. Puoi dire ad alta voce “io non separo”.
La SEAO lancia con questo numero di Archimetra l’iniziativa #iononseparo, fatta per sensibilizzare tutti gli operatori della nascita e i genitori sul tema dell’accoglienza umana dei nostri bambini, riconoscendo, insieme agli aspetti sanitari e di salute pubblica, che l’incontro, l’accoglienza empatica e il riconoscimento reciproco, sono le parole universali dell’amore.


Bibliografia
Klemming S, Lilliesköld S, Westrup B. Mother-Newborn Couplet Care from theory to practice to ensure zero separation for all newborns. Acta Paediatr. 2021; 110: 2951–2957. https://doi.org/10.1111/apa.15997
Bergman Nils J. (2014) The neuroscience of birth - and the case for Zero Separation : original research. https://hdl.handle.net/10520/EJC163018

Accedi per continuare la lettura!
Questo articolo è disponibile solo per gli abbonati. Se hai già un account, fai login qui sotto.
Se invece vuoi entrare nel nostro mondo di contenuti esclusivi, inizia da qui e scegli la tua membership!